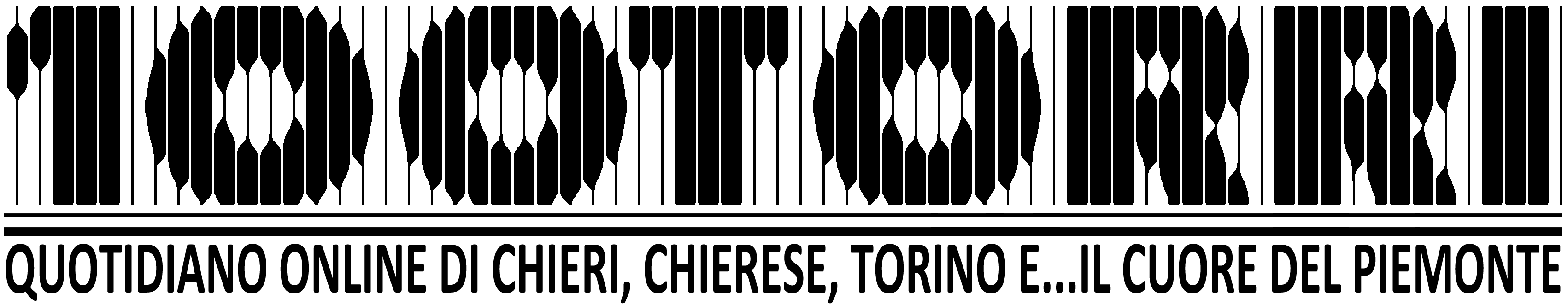Quando accompagnavo a casa la mia prima ragazza…
 Un tardo pomeriggio di un’altra epoca, nei vicoli alti di una Chieri troppo vecchia per poter divenire antica, impacciato e felice accompagnavo la mia prima “ragazza” a casa. Non credevo al vero, io, il suo primo “ragazzo”, spavaldamente e goffamente, la corteggiavo. La mano nella mano era incerta ma le parole volavano più veloci di un pensiero che non sapeva porsi in un ordine decente. I primi baci misero a disagio lei e me, ridere di ogni cosa ci aiutava a superare quella dolce confusione. Avremmo saputo dopo che avevamo allora avviata la nostra educazione sentimentale. Ci lasciavamo definitivamente alle spalle l’infanzia, dall’alto dei nostri 13 o 14 anni debuttavamo nel mondo sconosciuto della libertà. Il ’68 era appena passato -di striscio a Chieri- e se ne sentivano tutti i clamori lontani ma, anche qui da noi, aveva lasciato un’effervescenza vivace e multicolore in cui le mille idee assumevano importanza e profondità che rapivano la mente stupefatta. Troppo intenti nella scoperta della vita, non facevamo ancora differenza tra le piccole cose e quelle troppo grandi.
Un tardo pomeriggio di un’altra epoca, nei vicoli alti di una Chieri troppo vecchia per poter divenire antica, impacciato e felice accompagnavo la mia prima “ragazza” a casa. Non credevo al vero, io, il suo primo “ragazzo”, spavaldamente e goffamente, la corteggiavo. La mano nella mano era incerta ma le parole volavano più veloci di un pensiero che non sapeva porsi in un ordine decente. I primi baci misero a disagio lei e me, ridere di ogni cosa ci aiutava a superare quella dolce confusione. Avremmo saputo dopo che avevamo allora avviata la nostra educazione sentimentale. Ci lasciavamo definitivamente alle spalle l’infanzia, dall’alto dei nostri 13 o 14 anni debuttavamo nel mondo sconosciuto della libertà. Il ’68 era appena passato -di striscio a Chieri- e se ne sentivano tutti i clamori lontani ma, anche qui da noi, aveva lasciato un’effervescenza vivace e multicolore in cui le mille idee assumevano importanza e profondità che rapivano la mente stupefatta. Troppo intenti nella scoperta della vita, non facevamo ancora differenza tra le piccole cose e quelle troppo grandi.
Un treno, con una bella locomotiva di sorrisi e di risate e tanti vagoni di parole: questa era la mia “ragazza” che accompagnavo la sera verso casa. Impossibile immaginarla con un broncio o distaccata. Ogni oggetto del pensiero (per gli oggetti materiali non avevamo tempo, né lei, né io) diventava stupore e certezza allo stesso tempo, apprendevamo insieme e disordinatamente idee straordinarie. Senza saperlo ci stavamo preparando a dare fuoco all’apparente ordine pacato che ci aveva generati. Intanto, iniziavamo a conoscere il mondo e noi stessi. La sua impaziente foga di scoprire e capire non faceva fatica ad abbracciare le mie interrogazioni sul perché, domande mai espresse ma le cui risposte immediate erano fonte di solida sicurezza. Spendemmo, senza saperlo, parole importanti sul mondo e su di noi; avremmo saputo solo dopo che questo era il regalo più grande che potessimo fare l’uno all’altra.
 Venne poi la vita, la politica, l’impegno, l’amore per il sapere e per lo spiegare. Uno dell’altra sentivamo gli echi lontani rimbalzati dalle conoscenze in comune, mentre eravamo impegnati dimostrare al mondo che deve cambiare, come sempre.
Venne poi la vita, la politica, l’impegno, l’amore per il sapere e per lo spiegare. Uno dell’altra sentivamo gli echi lontani rimbalzati dalle conoscenze in comune, mentre eravamo impegnati dimostrare al mondo che deve cambiare, come sempre.
Quell’epoca lontana terminò poco a poco, facemmo percorsi diversi e lontani. Il tempo, con il suo vizio di andare avanti e indietro, colava ricordi isolati. Pochi incontri i nostri, distanti fra loro decenni, che riaccendevano sorrisi e abbracci a cui non mancava mai una sonora risata. L’edicola, una sera da amici che non sapevamo conoscere entrambi, un posteggio. Sorprese. Non erano, evidentemente quei momenti, gli attimi contemporanei dell’accadere ma ne erano, invece, la riproposizione nel presente di un passato che rifiutava le muffe del museo della memoria e tornava a modo suo farsi corpo, per un breve istante. Sapemmo, entrambi, complicarci la vita in ogni modo e immagino -ne sono certo- che anche lei, di fronte ai momenti più scuri, prima o poi, abbia alzato le spalle, fatta una risata e ripresa di corsa il percorso verso qualcosa, ogni volta diversa.
I giornali scrivono balle, lo sappiamo. Così lessi il nome Margherita sotto la sua foto. Ma questa bugia suonava strana: aveva un ché di troppo, una stortura del tempo in sé. Il tempo, si sa, va come vuole: accelera, rallenta, corre, scarta di lato, fa capriole, si ripresenta, si accartoccia su sé stesso ma non si ferma, mai. Quasi mai. Ma quella volta si è fermato, mentre mi dicevo “non è vero”. Sorrisi, alzai le spalle con lei, ancora mi stava abbracciando quell’ultima volta nel chiostro, ridendo. Non era vero, a quell’epoca.
Elio Limberti