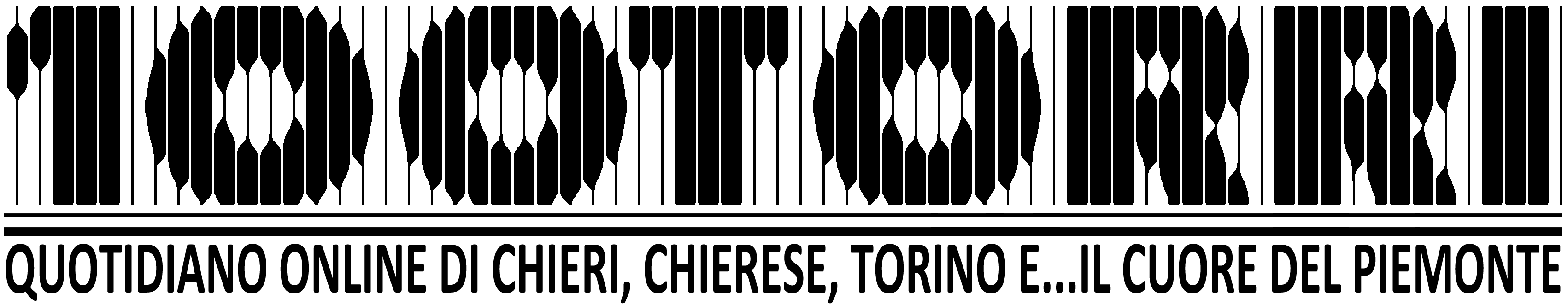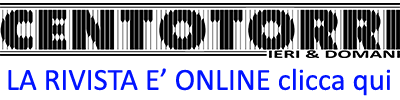Amarcord 25 aprile: nel 1975 con Olia, nel 1985 con Berruto, nel 2005 con Gay…
di Valerio Maggio

Il CLN chierese
Fra poche settimane festeggeremo l’ottantesimo anniversario della liberazione del nostro Paese dal giogo nazifascista con un Governo di destra-destra. Sarà curioso vedere come si comporterà nella circostanza forti del fatto che, negli ultimi anni, la ricorrenza del 25 Aprile, a livello centrale regionale e locale, è spesso scivolata, se non nell’indifferenza, in uno stanco ripetersi di atti privi di quella sincera e sentita partecipazione tanto cara alle generazioni del ‘900. Prendiamo il caso di Chieri. Dobbiamo tornare indietro di decenni prima di poterci imbattere – in riferimento agli avvenimenti che portarono l’Italia, attraverso la lotta partigiana, a liberarsi della tragica dittatura mussoliniana – in interventi non convenzionali ma di spessore. Ne cito tre in ordine cronologico partendo da quanto affermato nel 1975, in occasione del trentesimo anniversario della Liberazione alla presenza del comandante partigiano Barbato (Pompeo Colajanni n.dr.), dall’allora sindaco Egidio Olia. «Il tempo – scrive Olia – cancella dalla memoria degli uomini il segno di ciò che è avvenuto nel passato; ma vi sono insegnamenti che non debbono essere dimenticati, vicende della storia nazionale che si riflettono anche nella piccola storia della nostra città (…)». Per poi aggiungere: «Nel trentesimo anniversario della vittoriosa conclusione della Resistenza (…) non bisogna aver timore nel presentare ai giovani e nel riproporre alla memoria degli anziani, le debolezze del regime democratico degli anni ’20, le collusioni di interessi che hanno favorito l’ascesa al potere del fascismo, poiché dobbiamo ricordare ciò che scrisse, alla vigilia

Dal balcone del ristorante della stazione l’annuncio della liberazione
della fucilazione, uno dei molti giovani eroi della Resistenza: “Tutto ciò è avvenuto perché non ne avete più voluto sapere” (…). Occorre far sentire [ai giovani] che la libertà è una conquista di ogni giorno e che si può perdere per le nostre debolezze ed il nostro qualunquismo quotidiano; soprattutto ricordare quanto costa, di lacrime e sangue, riconquistarla (…) ricordando ai cittadini chieresi quanti, per garantirci una vita da uomini liberi hanno cospirato e lottato nei nostri paesi e sulle nostre colline: intellettuali e operai, contadini e soldati, cattolici e socialisti, comunisti e liberali». Negli anni ’80 toccherà al sindaco Giuseppe Berruto – democristiano come il precedente, anche lui proveniente dalla scuola di Carlo Donat Cattin di Guido Bodrato – ribadire come «quella data segnò la fine della politica del terrore e dei tristi presagi di una moderna schiavitù all’ombra di Hiltler; la fine delle deportazioni, della caccia all’ebreo, dei delitti contro le minoranze etniche». «Se anche la distanza di quegli eventi si è fatta lunga – riaffermerà con slancio – se non sempre i modi di ricordare e di celebrare quella vittoria è stata in grado in grado di aiutarne una lettura limpida di quello che fu (la liberazione dell’umanità, e quindi di tutti, dal giogo di una barbarie come mai si era visto nella storia dell’uomo) oggi è più che mai il tempo di respingere il tentativo di ridimensionare la vicenda della Resistenza, riducendola a guerra civile tra due parti di un popolo in lotta fra loro. Oggi che per tutti la scelta antifascista è diventata un valore, ricordare uomini e drammi di allora è fare opera di giustizia e di libertà». Nel sessantesimo anniversario Agostino Gay primo sindaco di sinistra si rivolgerà alla città per rinnovare: «Il ricordo della fine di una guerra così totale, così sanguinosa. [Il ricordo] è un dovere per chi è

1975. Barbato con il sindaco Olia
sopravvissuto e per chi della pace che ne è seguita ha usufruito (…). Sento di essere grato a chi, pur con le armi, ha creato le condizioni per l’affermarsi in Italia ed in Europa della democrazia. Grato alle nazioni che misero in campo i loro eserciti, che sacrificarono tanti loro cittadini per arrestare le politiche di sopraffazione e di morte messe in atto dai cultori di una supremazia di una razza. Grato a chi seppe ribellarsi, scegliendo di aderire spontaneamente ad un movimento che riscattò le acquiescenze dei molti, dei troppi che non avevano ostacolato, quando non vi avevano inneggiato, l’introduzione delle leggi razziali e l’occupazione di altri stati sovrani. A chi lasciò la propria famiglia, il proprio reparto per contribuire alla Liberazione (…) ai milioni di persone che pagarono con la vita la politica distruttrice di una classe dirigente assetata di potere che, in nessun modo, teneva conto dei principi di giustizia e di libertà».